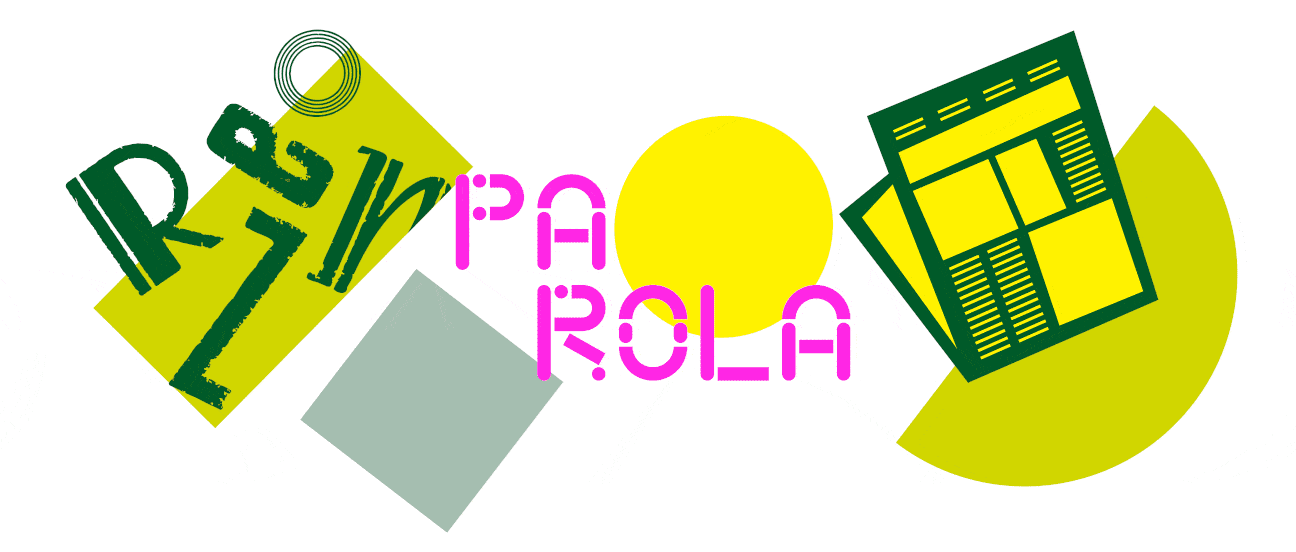
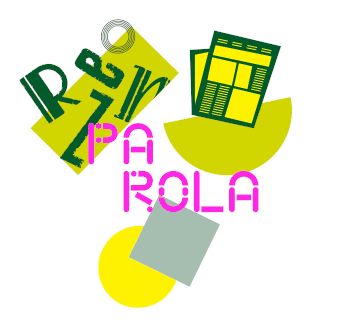
La “parola” è un complesso di suoni o fonemi, articolati nella loro forma scritta in un insieme di lettere. Essa costituisce l’unità minima che compone una frase ed è capace di esprimere un significato, in alcuni casi preciso, in altri generico. Se isolata, la parola vive infatti in una sfera semantica specifica che appartiene alla lingua di chi parla; allo stesso tempo non ha un senso assoluto ma assume un particolare valore in base al contesto in cui viene usata.
La parola pronunciata, detta parola orale o fonologica, è restituita da accenti e intonazioni che ne favoriscono la migliore comprensione. “Parlare” significa certamente “pronunciare delle parole” ma, in base a come e a cosa si comunica, può prendere diverse accezioni come “riferire” o “conversare”, “manifestare un’opinione” o “narrare”. “Parlare in pubblico” è addirittura da sempre una vera e propria arte, l’oratoria, che già nel IV sec. a.C. Aristotele distingueva in politica, celebrativa o giudiziaria.
Quando è trascritta, la parola è un segno che rispetta le convenzioni grafiche del contesto semantico a cui appartiene. L’azione della trascrizione grafica delle parole indica l’atto dello scrivere: in casi non ordinari, anche la scrittura corrisponde a una vera e propria arte, la cosiddetta “calligrafia” (dal greco calòs “bello” e graphìa “scrittura”). La calligrafia araba, ad esempio, è usata nell’arte musulmana ed è spesso così ornata da risultare quasi illeggibile. In Cina e Giappone si tracciano gli ideogrammi con inchiostro e pennelli, attraverso gesti fluidi e segni modulati, per ottenere una delle più raffinate forme di pittura. Molti artisti del ’900, ad esempio Franz Kline, sono fortemente influenzati dalle tecniche calligrafiche o hanno costruito nuovi alfabeti visivi, come nel caso di Giuseppe Capogrossi. Nell’opera del pittore statunitense Cy Twombly si assiste invece alla creazione di un ulteriore universo grafico dove l’artista, liberato da qualsiasi costrizione logica o formale, si avvale di segni primari che mostrano sé stessi nel loro puro ed essenziale valore estetico.
Il potere della parola di affermare qualcosa o, a volte, di rimandare al significato opposto, di essere quindi ambivalente o addirittura - se allontanata da qualunque contesto - di non esprimere assolutamente niente, l’ha resa uno degli elementi di rottura delle avanguardie del secolo scorso. I cubisti, come Georges Braque, inseriscono nella tela ritagli di riviste per affermare i propri intenti o valori, tramite un linguaggio, quello pittorico, fino ad allora considerato non verbale. Diverso, e per certi aspetti più radicale, è l’interesse attorno al valore grafico ed evocativo della parola dei futuristi, che inseriscono onomatopee o giochi di lettering per una percezione sinestetica dell’arte.
“Dada non significa nulla” proclama il poeta romeno Tristan Tzara, primo tra i dadaisti a trattare, seppur con indifferenza, le parole per quello che sono: suoni o segni. Per Marcel Duchamp la parola è un elemento fondamentale: i titoli delle opere gli permettono di esprimere ambiguità semantiche, giocare con doppi sensi o contro sensi, aggiungere poesia ai suoi ready made. Duchamp è sicuramente l’icona del radicalismo artistico del XX secolo, la cui poetica influenzerà gli artisti delle generazioni seguenti. Ad esempio, per Bruce Nauman la parola è la materia prima di alcuni lavori: nelle sue opere-video pronuncia, biascica, grida o ripete ossessivamente le più disparate parole, fino a togliere loro ogni minimo senso. Diversamente, nei suoi neon la parola, che per definizione è qualcosa di immateriale, prende forma e corpo, diventando tangibile. Anche Mario Merz si serve del neon per dare alle sue frasi la giusta risonanza grazie alla luce che il tubo emana: Merz “accende” letteralmente le parole con il fine di dare forma al potere del pensiero e alla forza ispiratrice delle idee.
